Le Rubriche
ROMA ANTICA Il culto di Angizia
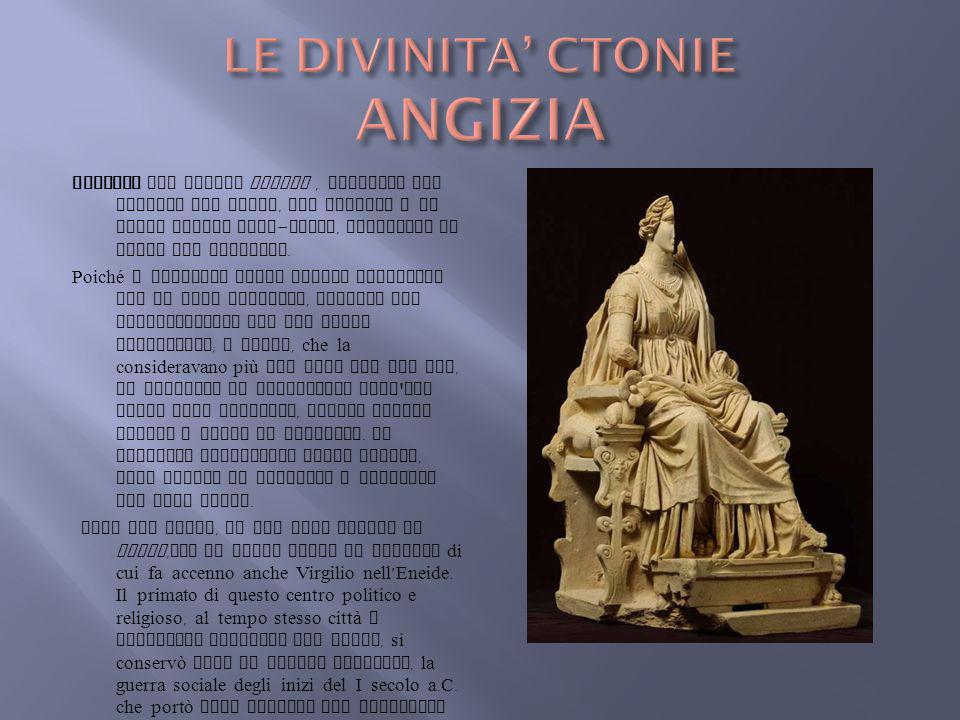
ROMA ANTICA Angizia era una divinità adorata dai Marsi, dai Peligni e da altri popoli osco-umbri, associata al culto dei serpenti. Identificata come figlia di Eeta e sorella di Circe e Medea. Poiché i serpenti erano spesso collegati con le arti curative, Angizia era probabilmente una dea della guarigione.
I Marsi consideravano Angizia più una maga che una dea. Le dovevano la conoscenza dell’uso delle erbe curative, specie quelle contro i morsi di serpente. Le venivano attribuiti altri poteri, come uccidere i serpenti col solo tocco. Dai romani a volte veniva associata alla Bona Dea. L’antica diffusione della devozione alla dea in vaste zone dell’Italia centro meridionale e la tradizione di cerimonie che si svolgono a metà primavera in diverse contrade rivelano di un rito propiziatorio della fertilità. Era nota come Anctia fra i Marsi e Anagtia presso i Sanniti. Ad Aesernia le veniva riservato l’appellativo di diiviia.
I Peligni la chiamavano Anaceta o Anceta. A Corfinium esisteva il culto fra le donne. Era invocata con l’attributo di Keria. Voce che richiama il sumero kur (terra), l’accadico kerû (terra coltivata, orto) e il latino Cerere (terra, fertilità). È suggestiva la corrispondenza della dea italica alla divinità iranica Anahita o Anchita, compagna di Mitra, nome sumero del sole, e alla dea assira Ištar, anch’essa dea della fecondità. Se Angitia, Anagtia, Anceta, Anaceta, Anahita sono la stessa divinità ne consegue che condividono il significato del nome.
Anahita vuol dire ‘colei che viene in soccorso, che sta accanto’. Il termine è costituito dalle componenti accadiche an (accanto, per, verso) e aḫitu (fianco, lato), pertanto pronunciarlo sarà valso come un’implorazione di aiuto. Il bosco sacro che secondo Virgilio era dedicato alla dea Angizia si trova nei pressi del sito archeologico di Lucus Angitiae, alle porte di Luco dei Marsi. La singolare cerimonia dello Spirito Santo che si svolge a Luco nel giorno di Pentecoste prevede, indizio rivelatore, l’imprescindibile presenza degli zampognari con sosta presso i ruderi del tempio italico di Anxa, nome romano derivato dal toponimo in lingua marsa Actia, a cui sarebbe connesso anche il nome della dea Angizia.
IL BOSCO SACRO
A Cocullo il primo giovedì di maggio si svolge la festa dei serpari, ora dedicata a san Domenico, che sarebbe derivata dal culto pagano di Angizia. Numerose le ricorrenze religiose in altri luoghi della Marsica e dell’Abruzzo con pratiche all’aperto e presso le tante chiese dedicate alla Madonna delle Grazie e alla Madonna della Neve che richiamano il culto della divinità italica della fecondità. Il toponimo del bosco sacro presso il santuario di Angizia (Lucus Angitiae) sopravvive nel nome della cittadina di Luco dei Marsi. La squadra di calcio di Luco dei Marsi è stata denominata Angizia Luco.
Attualità
Kipin, Il biglietto da visita digitale che salva alberi e connette persone

In un mondo sempre più connesso e digitale, anche il gesto più semplice, come quello di consegnare un biglietto da visita, sta subendo una profonda trasformazione. Ma cosa succede quando innovazione tecnologica, attenzione all’ambiente e cura per l’identità aziendale si incontrano?
Nasce Kipin, una piattaforma che sta rivoluzionando il concetto di biglietto da visita, trasformandolo in uno strumento intelligente, completo, sostenibile e perfettamente integrabile nei flussi aziendali. Kipin non è solo un prodotto, è una visione. Dietro l’idea c’è Cristiano Vitolo, sviluppatore appassionato fin dall’età di dieci anni, che dopo anni di esperienza tra web agency, multinazionali e startup ha deciso di creare qualcosa che potesse fare la differenza, non solo nella sua vita, ma nel mondo intero. Così è nata una piattaforma capace di rispondere a un bisogno concreto: creare biglietti da visita digitali belli da vedere, facili da condividere e capaci di evolvere con chi li utilizza.
L’idea che nasce da un bisogno personale
Come spesso accade, le grandi idee nascono da necessità personali. Vitolo sentiva l’esigenza di gestire più biglietti da visita con identità grafiche differenti, per i vari progetti che seguiva. La prima versione di Kipin era pensata per singoli professionisti, ma presto le richieste delle aziende hanno indicato una nuova strada, dando vita a una piattaforma pensata anche per le realtà corporate, con funzionalità avanzate e integrazioni pensate per reparti sales, HR e marketing.
Kipin non è l’ennesima app per scambiarsi il numero di telefono. È invece un ecosistema totale, completo, un ponte tra la presentazione e la relazione, tra il design e la funzionalità, tra il primo incontro e il prossimo contratto. Kipin nasce infatti da chi ha sbagliato, imparato e solo dopo costruito.
Un impatto reale sull’ambiente
Oltre l’innovazione tecnologica, Kipin porta con sé un importante messaggio ambientale. Ogni anno, miliardi di biglietti da visita cartacei vengono stampati e rapidamente gettati via, ben l’88% di essi finisce nella spazzatura già poco dopo essere stato consegnato.
Kipin propone un vero e proprio cambio di paradigma: niente più sprechi di carta, niente più abbattimenti di alberi. Anzi, più utenti si iscrivono, più alberi vengono piantati. “Abbiamo già compensato oltre 86 tonnellate di CO2.” afferma Vitolo, sottolineando come la sostenibilità sia parte integrante della visione dell’azienda. Non a caso, molte realtà del mondo green sono tra le prime ad aver adottato Kipin.
Il biglietto da visita che non si perde (e che evolve)
Il cuore dell’offerta è una piattaforma accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Il biglietto da visita digitale di Kipin non si perde mai, resta sempre aggiornato, condivisibile e facilmente modificabile in tempo reale, ogni card può essere personalizzata nel layout, nei colori, nel font e perfino nell’URL. Inoltre, ogni utente può gestire più versioni del proprio biglietto, scegliendo cosa condividere e con chi, a seconda del contesto. Le funzionalità sono davvero molteplici: QR code dinamici, conferme di lettura, analytics su visualizzazioni e interazioni, accesso tramite Single Sign-On (SSO), ma anche integrazioni con Zapier, applicazioni, CRM e directory aziendali.
L’attenzione al design fa la differenza
In un tempo in cui tutto è standard, Kipin punta invece sulla personalizzazione visiva.
I template proposti dalla piattaforma sono solo un punto di partenza, ogni cliente può ricevere una card completamente su misura, in linea con la propria brand identity. Questo rende Kipin non solo uno strumento funzionale, ma anche un veicolo potente per l’immagine aziendale.
“Passare al digitale non deve significare perdere identità.” spiega Vitolo.
“Anzi, al contrario, il nostro obiettivo è aiutare le aziende a valorizzare la propria immagine, con un biglietto che è anche uno strumento di marketing e comunicazione.”. L’interfaccia utente della piattaforma è intuitiva, pensata per offrire un’esperienza fluida anche a chi ha poca dimestichezza con gli strumenti digitali.
Oltre l’app: card fisiche intelligenti
Per chi invece desidera ancora oggi un oggetto fisico da poter mostrare e portare con sé, Kipin ha sviluppato anche soluzioni NFC personalizzabili, come le card in bambù incise al laser, le card in acciaio premium, i bracciali e tag NFC da 18mm (i più piccoli sul mercato italiano). Tutti i dispositivi sono riutilizzabili e collegati al proprio biglietto da visita digitale, che può essere aggiornato o riassegnato in caso di necessità. Anche qui, l’obiettivo è unire innovazione, estetica ed ecosostenibilità, tutto con un sistema di sicurezza che consente, in caso di smarrimento, di sospendere la card direttamente dalla console di gestione. Kipin non ha potuto contare su grandi investimenti, anzi, ha costruito la sua crescita passo dopo passo, autofinanziandosi, testando sul campo, sbagliando e riprovando.
Un approccio che oggi ripaga con una base clienti in costante espansione e una reputazione solida nel mondo del digital networking. Dal 2017, Kipin si è quindi evoluta senza l’intervento di investitori esterni, una crescita organica guidata da ascolto dei clienti, testing e miglioramento continuo, ogni funzionalità oggi disponibile è nata da un bisogno reale, sperimentato in prima persona dallo stesso team.
I numeri premiano l’iniziativa: la piattaforma è oggi utilizzata attivamente da oltre 40.000 utenti, adottata anche da imprese strutturate con oltre 4.000 dipendenti, il numero di condivisioni dei biglietti da visita sopra 1 milione e mezzo. Tutte le figure che hanno bisogno di presentarsi (ed essere ricordate), creare connessioni in modo professionale e sostenibile, possono oggi usufruire di una piattaforma come quella di Kipin.
Guardando al futuro: identità digitale e AI
Nei prossimi anni, l’obiettivo di Kipin è diventare uno standard per l’identità digitale. Quindi, non solo biglietto da visita, ma anche pass digitale per fiere, eventi, incontri, un unico strumento per presentarsi e connettersi. La visione di lungo periodo punta a rendere Kipin una piattaforma orizzontale, capace di dialogare con tutte le principali tecnologie e dispositivi utilizzati nel mondo del business.
In arrivo anche nuove funzionalità basate sull’AI, soprattutto per la gestione avanzata dei contatti e dei lead. Un modo per unire ancora di più tecnologia e praticità, offrendo alle aziende strumenti concreti per aumentare la produttività e migliorare il ROI delle attività commerciali.
Non chiamatela startup
Anche se nata nel 2017, quindi una realtà giovane e innovativa, oggi Kipin non si riconosce più nell’etichetta di “startup”. Dopo anni di sviluppo costante, crescita organica e consolidamento di una base clienti stabile, Kipin è un’azienda strutturata, solida e completamente indipendente, capace di camminare con le proprie gambe senza investimenti esterni. La sua storia parla di resilienza, ma soprattutto di affidabilità: un team tecnico stabile, un prodotto maturo e un modello di business sostenibile sono oggi la garanzia di una piattaforma pensata per durare, evolversi e accompagnare le aziende nel lungo periodo. Perché l’innovazione, qui, non è più una promessa. È realtà quotidiana.
La forza di crederci (anche nei momenti difficili)
Come ogni progetto imprenditoriale, anche Kipin ha vissuto momenti di incertezza, ma è proprio in quei momenti che la visione di lungo periodo e la passione per l’innovazione hanno fatto la differenza. “Ci sono stati momenti in cui ho pensato di mollare tutto, ma l’amore per il progetto e la consapevolezza che non aveva ancora espresso tutto il suo potenziale mi hanno spinto ad andare avanti.” confida Vitolo.
M oggi Kipin è pronta per il salto, diventare il punto di riferimento per il networking digitale sostenibile in Italia (e non solo). “Connection and trees growing together”, uno slogan, una missione, una promessa mantenuta.
Per maggiori informazioni
Sito Internet: https://kipin.app
Meteo
Meteo Roma. L’avviso del Comune bollino rosso

Elevate temperature nella Capitale: sabato 14 e domenica 15 è previsto il livello 3 (bollino rosso).
Il comune di Roma ha appena diramato una comunicazione ufficiale sulle prossime previsioni meteo a Roma.
Meteo Roma caldo a livello 3
Con il livello 3 si intendono temperature elevate che persistono per più giorni consecutivi con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su soggetti a rischio).
É attivo il piano straordinario di interventi per l’assistenza alla popolazione durante il periodo estivo. In particolare:
Saranno allestiti tre presidi della Croce Rossa dotati di tende climatizzate, posizionati in aree strategiche del centro città. Questi punti offriranno un servizio di prima assistenza e informazione socio sanitaria rivolte sia ai pellegrini sia alla cittadinanza, per fronteggiare le emergenze legate alle alte temperature.
La Protezione Civile capitolina invita tutti a scaricare l’opuscolo informativo con i comportamenti da adottare
Roma Capitale invita inoltre a scaricare l’app Acquea creata da Acea per segnalare le fonti di acqua a disposizione in città.
-

 Roma e dintorni15 ore ago
Roma e dintorni15 ore agoRoma, uomo trovato impiccato a Rocca di Papa: vicino rinvenute altre ossa
-

 Calcio20 ore ago
Calcio20 ore agoSvelate le nuove maglie della Roma 2025/26: il dettaglio nascosto che ha fatto impazzire i tifosi!
-

 Video1 giorno ago
Video1 giorno agoTurista scopre di essere stato derubato e immobilizza una borseggiatrice a terra e la fa arrestare VIDEO
-

 Roma e dintorni3 giorni ago
Roma e dintorni3 giorni agoIncidente a Roma, scontro tra auto e moto su via Ostiense: un morto




